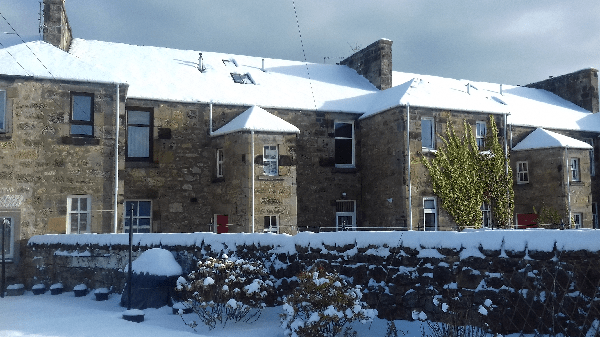Argentina: agricoltori nella pampa

Para amar la Patria Grande,
hay que conocer y amar la Patria Chica
(Vermiro Ayala Gauna) ‘Terra generosa, terra che aspettava, ma quando fu raggiunta nel suo grigiore monotono, immenso ed uguale, sgomentò i primi lavoratori: se non vede un orizzonte, anche il più audace degli uomini perde animo e coraggio; i sensi umani hanno bisogno di appoggiarsi su un confine o, almeno, di immaginarlo.
Terra sterminata la pampa, più si procedeva e più pareva di essere al primo passo; una terra senza nodi e senza poesia, ma appunto, perché tale, d’una monotonia, d’una durezza da piegare i giganti.
E poi c’era quel cielo che non si capisce dove comincia e dove finisce…resistere a quel cielo era difficile perché non soltanto monotono e duro come la terra, ma staccato, lontanissimo: impossibile comprenderlo con lo sguardo, quasi persino crederlo vero…il cielo della pampa non ha rapporti con il basso, ha le sue stelle e le sue nuvole, ma così distanti, così perse nello spazio che converrebbe abbandonare la terra e sentirsene staccati per appoggiarvi lo sguardo con confidenza E poi le notti nella solitudine, il pampero, i tramonti brevi, le albe lunghissime, i crepuscoli teneri, carezzevoli, persino estenuanti!’
Le parole dello scrittore senigalliese Mario Puccini ben si adattano a quella piana infinita ed angosciante, che con i suoi prodotti e la sua mentalità, continua ad influenzare la vita dell’Argentina, a prescindere dall’economia, dalla politica e dalla cultura che vi regna, come scrisse il francese Roman Gaignard.
La colonizzazione della pampa iniziò nella provincia santafesina ad opera dei gringos, termine col quale i criollos chiamavano i coloni europei in generale (ai galiziani era riservato il termine gallegos); turchi, armeni e arabi erano turcos, russi, ebrei e tedeschi rusos.
La prima colonia della pampa gringa – come lo scrittore Alcides Greca la chiamò più tardi – fu battezzata Esperanza. Venne fondata nel 1853 da Aarón Castellanos che assunse direttamente duecento famiglie europee (in prevalenza svizzere e tedesche), dopo aver siglato un contratto con il presidente Urquiza.
Nel 1882 Esperanza era già diventata una cittadina molto importante: le famiglie erano già settecentocinquantasei e vi abitavano già circa mille italiani.
La seconda colonia in ordine cronologico fu San Carlos: fu fondata dall’impresa Beck e Herzog, grazie a famiglie provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia.
I primi contratti, depositati presso l’Archivo General de la Nación, prevedevano la consegna a ciascuna famiglia di
‘un terreno di 20 cuadras (equivalente di 33 ettari), i materiali necessari per la costruzione di un ranch (capanna), quattro buoi mansueti, due cavalli, quattro vacche da latte, due vitelli e due maiali, i viveri necessari per un valore di 60 pesos a persona adulta, i semi necessari per la semina del terreno.
I coloni a loro volta si obbligavano a consegnare all’impresa la terza parte del raccolto a cadenza annuale, a partire dal giugno successivo all’arrivo nella colonia, nonché, allo scadere dei cinque anni, la metà di tutti gli animali nati nel frattempo. Alla fine del periodo, adempiuto quanto sopra, la famiglia diventava proprietaria della terra e di tutto quello che produceva’.
La terza colonia, San Jerónimo, fu fondata nel 1859 da Ricardo Foster; nel 1870 sorse Mauricio Franck ed ancora Santa Maria Norte, Candelarias, Pilar. Presidente Roca, Colonia Aldao, Fidela e Galvez.
L’emigrazione marchigiana, iniziata con forte ritardo rispetto a quella del resto d’Italia, non riuscì ad inserirsi nel primo ciclo, quello della distribuzione gratuita delle terre. I marchigiani concorsero sì allo spostamento della frontiera gringa, ma si trovarono a sfruttare aree marginali e a lavorarle tramite contratti di affitto e sub – affitto, essendo emigrati 20-30 anni dopo piemontesi, friulani e liguri.
La pampa fu indubbiamente una terra generosa, ma volle sentirsi conquistata in profondità e pretese dagli uomini un amore continuo, chiuso e geloso. Se essi avessero speso soltanto forza e sudore, il loro slancio non sarebbe stato ripagato; molti di loro avrebbero finito col lasciare il lavoro a metà…e via di corsa in cerca di una terra, magari meno fertile ma più accogliente.
Fu una battaglia lunga e dura quella che intrapresero ma vittoriosa: quei coloni strinsero i denti e chiusero gli occhi, la fede in sé stessi li nutrì e li soccorse. Ma anche un pensiero li nutrì e li soccorse, quello di andare avanti fino alla fine.
Il mito del fare l’America durò pochi anni: già negli Ottanta si fece avanti la figura del peón, il salariato agricolo o urbano, alle dipendenze dei capitalisti argentini, inglesi e talvolta di coloni ed imprenditori italiani.
Nelle province cerealicole della costa e dell’interno, dove erano coltivati grano, mais, lino, patate, fagioli (al nord si privilegiava canna da zucchero e alfalfa), la manodopera era così costituita:
-braccianti stabili: abitavano nella colonia o nei pressi, svolgendo d’inverno ogni tipo di manovalanza (carrettieri, ortolani, manovali), mentre d’estate partecipavano alle varie fasi del raccolto. Erano preferiti dai coloni, perché esperti in tutti i lavori agricoli;
-braccianti avventizi: d’inverno abitavano in città dove lavoravano nei porti, nelle fabbriche o alla costruzione di ferrovie;
-golondrinas: venivano a fare la stagione approfittando della sospensione dell’attività agricola in Italia (dicembre era il mese del raccolto del grano e marzo quello del mais).
I braccianti avventizi e le golondrinas si spostavano da una colonia all’altra alla ricerca di lavoro e per questo venivano chiamati lingeras.
I braccianti lavoravano tutta la giornata, con due ore di riposo distribuite in tre fasi. Erano retribuiti a cottimo ed in più ricevevano carne, gallette e mate. Il loro salario oscillava all’equivalente di settanta – centoventi lire al mese, e variava secondo la stagione, il luogo e l’abbondanza del raccolto.
Una famiglia di quattro – cinque persone poteva guadagnare durante la stagione l’equivalente di mille – milleduecento lire; da questa somma doveva essere detratta la spesa per il curandero, cui dovevano ricorrere per insolazioni, febbri ed infortuni sul lavoro.
Nel periodo della cosecha (raccolta), le ferrovie praticavano sconti dal 20 al 50% per gruppi di braccianti.
I peones partecipavano anche alla raccolta del granturco: anche qui erano pagati a cottimo, un tanto per ogni sacco di pannocchie (ottanta chili); in una giornata potevano arrivare a confezionare venti sacchi.
Pantanetti ci informa dettagliatamente sulla situazione nella provincia di Santa Fe dove viveva:
‘Il periodo dei grandi guadagni è rappresentato per essi dall’epoca della raccolta: sono i mesi di novembre, dicembre, gennaio e marzo quelli che da soli dan da vivere per tutto l’anno e permettono di mettere da parte qualche soldo. Prima la mietitura (che per quanto fatta a macchina richiede un notevole numero di braccia di scorta), poi la trebbiatura. Qui il proprietario della macchina deve portare con sé tutto il personale necessario, dal macchinista e fuochista fino all’uomo di cucina che fa da mangiare per tutti; un complesso di 16 o 18 persone.
Da ultimo resta la raccolta del mais: in questo periodo, essendo finite le altre faccende, un gran numero di braccianti marchigiani viene a riunirsi per qualche settimana nei pressi di Rosario ove prevale la coltura di questo cereale. Un buon lavoratore può in tutto questo periodo guadagnare fino a 400 pesos.
Durante il resto dell’anno, qualcuno si pone a servizio nei grandi magazzini- deposito di cereali da cui inizia il movimento di esportazione o nei molini o si pone a mesata presso coloni scarsi di braccia in famiglia: ma in questo tempo la giornata è assai più scarsa arrivando al pagamento di L. 2,20 ed il vitto’.
Annotava Pantanetti che i marchigiani proprietari di terre non erano molti in proporzione al numero totale:
‘Essi vivono in comoda agiatezza e caratteristica curiosa, mentre nella gran parte dei contadini marchigiani resta vivo il desiderio di un ritorno più o meno pronto in patria, nei primi sparisce questo desiderio, al punto che, pur trovandosi in condizioni prospere, non sentono il bisogno di fare neppure un viaggio di piacere: al contrario del colono ricco piemontese che fa di norma due o tre viaggi in patria’.
Per quanto attiene alla proprietà della terra, il giornalista Antonio Franceschini così scriveva nel 1908:
‘Chi non l’aveva ricevuta gratuitamente (in genere 1 o 2 concessioni di 20 cuadras ognuna, cioè 30 ettari), la pagò all’inizio tra le 100 e le 400 lire italiane a concessione, a seconda del terreno, della distanza dal centro abitato, della presenza della ferrovia, dell’acqua.
Il pagamento era in genere effettuato con un acconto iniziale e con 4 cambiali con scadenza di 6, 12, 18, 24 mesi, con un interesse annuo del 10% da pagarsi assieme alla cambiale; a garanzia c’era l’ipoteca sul terreno stesso.
Frodi e difficoltà erano annesse a qualsiasi contratto, da quelle inerenti l’effettiva qualità della terra a quella sulla misurazione del terreno, alla consegna dei titoli di proprietà…
Ottenuta la terra, la prima fase dell’impianto dell’azienda era assai difficile. Chi aveva ottenuto la terra gratis, aveva avuto anche un anticipo di sementi, animali e attrezzature per lavorarla; gli altri si rivolgevano all’impresario della colonia o al piccolo commerciante per avere a credito tutto il necessario’.
I marchigiani compresero ben presto che era difficile realizzare nella pampa húmeda un sistema agricolo simile a quello della nostra regione. Ad essi venivano assegnati appezzamenti di terreno dalle caratteristiche del tutto sconosciute, troppo estesi per potervi adattare l’organizzazione della piccola azienda mezzadrile marchigiana.
Il tessuto sociale risentì fortemente di tale configurazione produttiva: gli emigranti non ritrovavano i caratteri del borgo rurale e soffrivano molto l’isolamento delle grandi estancias, cui non erano abituati. Non era poi possibile contare sulla solidarietà dei vicini che costituiva un punto fermo del lavoro rurale nella realtà mezzadrile marchigiana, specialmente nei più importanti momenti del ciclo agricolo (mietitura, raccolta dell’uva e delle olive o macellazione delle carni); ciò permetteva di ottenere prestazioni d’opera ricambiate in seguito nello stesso modo, tanto da integrare la conduzione familiare con manodopera aggiuntiva a costo zero.
Anche le condizioni ambientali creavano loro problemi sconosciuti ed inaspettati: il clima si rivelava difficile, causa la frequenza di calamità naturali come la siccità, le inondazioni, i venti gelidi delle Ande che impoverivano la terra; tutti questi fattori, unitamente a flagelli sconosciuti in Italia (locuste e topi), compromettevano i raccolti con una frequenza quasi triennale, contro l’intervallo calcolato in nove, dieci anni che passava in Italia tra una carestia e l’altra.
Ma proseguiamo con il lavoro: superate le prime fasi, occorreva affrontarne altre; si seminava a giugno e si raccoglieva a dicembre, di norma senza lavoro intermedio.
Per l’aratura e la semina veniva impiegato tutto il nucleo familiare, mentre per la mietitura e la trebbiatura si ricorreva a braccianti ed all’affitto di macchine. In genere il proprietario organizzava da solo il trasporto del raccolto fino alla ferrovia e poi la vendita dello stesso; spesso finiva per essere defraudato di una parte considerevole del guadagno, essendo costretto a disfarsi subito del grano e dei semi di lino, non avendo depositi adeguati per conservarli.
I margini di guadagno erano tanto più alti quanto l’esistenza del colono era improntata ad un basso tenore di vita. Il colono italiano era preferito proprio per questo, perché produceva ad un costo minore
Se calcoliamo il numero degli italiani partiti tra il 1876 e il 1900 (pari a 801.362 unità) ed il numero dei proprietari italiani menzionato dall’economista Luigi Einaudi al 1900 (62.975), constatiamo che fino a quel momento solo il 7,8% era riuscito nell’impresa.
Padre Donzelli si sofferma sui sacrifici sopportati da quelli che ce l’hanno fatta.
Se buona era la situazione economica raggiunta dei proprietari, lasciava molto a desiderare, secondo Donzelli, la loro condizione morale:
‘Il benessere finanziario ha dato ad essi una certa presunzione che disdice troppo col loro analfabetismo o quasi. Molti hanno dimenticato o trascurato il principio religioso cristiano che domava i loro istinti spesso un po’ brutali, onde si osservano disordini morali gravissimi.
I giovani poi, cresciuti in questo ambiente di corruzione, non avendo neppure il freno che i loro padri hanno portato d’Italia coll’educazione cristiana, minacciano di divenire peggiori.
Molto si potrebbe fare pel loro miglioramento sia materiale che morale; ma ciò è vano sperare da uno stato ove tutto è corruzione e venalità; quindi dovrebbero i coloni cercarlo in sé stessi. Ma chi li guiderà? La guida naturale sarebbe il clero ma purtroppo qui non ha né capacità né voglia.
Anzitutto il colono è diffidente in modo da non credersi, diffidenza giustificata da quanto si è fatto da tutti, preti compresi, per sfruttare i suoi lavori e risparmi.
In secondo luogo i sacerdoti sarebbero incapaci per la loro educazione insufficiente e per la loro posizione sempre precaria. Al miglioramento materiale e morale sarebbe necessario sviluppare nei coloni il sentimento della solidarietà, riunirli in cooperative specie di consumo, e a queste cooperative, ben dirette e sviluppate, unire il compito di formare scuole e collegi per una buona istruzione ed una migliore educazione cristiana, non a base di devozioni più o meno sante, ma a base di principi che informino tutta la loro condotta morale.
Queste cooperative potrebbero provvedere ai soci assistenza medica, farmaceutica e in molti luoghi anche religiosa. Sottratti i coloni all’usura delle case di negozio, educati cristianamente ed istruiti convenientemente alla loro condizione, potrebbero raggiungere uno stato di prosperità veramente invidiabile.
Allora sparirebbe anche la possibilità che i rappresentanti dell’autorità governativa fossero persone indegne e commettessero i soprusi e le infamie che oggi impunemente commettono. Tutto ciò però non credo ora possibile per mancanza di persone che si dedichino con coscienza e capacità e costanza a quest’opera santa della rigenerazione morale ed anche materiale dei nostri connazionali!’
Le chiese e le scuole rappresentarono per i coloni degli autentici lussi al punto che, molti anni dopo il loro arrivo, erano ancora carenti in molte zone.
Un’ importante testimonianza in tal senso mi arriva da Inés Lambertucci, figlia di Umberto e nipote di Gelasio Nazzareno, nato a Tolentino nel 1893 e trasferitosi in Argentina quasi ventenne.
A Porteña, Gelasio e la moglie organizzarono dapprima una scuola ‘in una, poi due stanze, nella parte retrostante della propria casa’; poi quando questa divenne troppo piccola, ‘decisero di cedere un pezzo di terra in un angolo della fattoria per la costruzione di una vera scuola che ancora funziona’.
Si chiama Escuela n. 26, Islas Malvinas e Inés me ne parla commossa:
‘Ricordo che mi portarono a vedere la fattoria e ad un tratto suonò la campana ed i ragazzi uscirono in ricreazione… I nonni furono i padrini ed i benefattori della scuola, sempre. Questa cosa mi sembra molto importante: erano persone semplici e si erano sacrificati tutta la vita. Non avevano molta terra, ma trovarono ugualmente lo spazio per accogliere le aule, ebbero la generosità di restituire con qualcosa, ciò che questo Paese aveva tanto dato loro. Non devo considerarli un esempio di vita?
Paola Cecchini