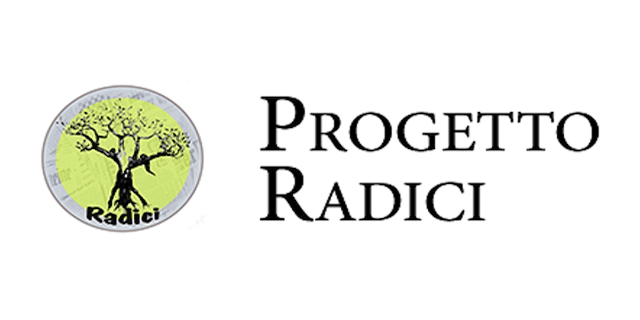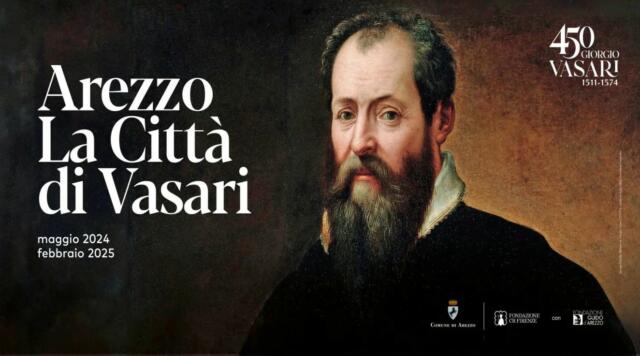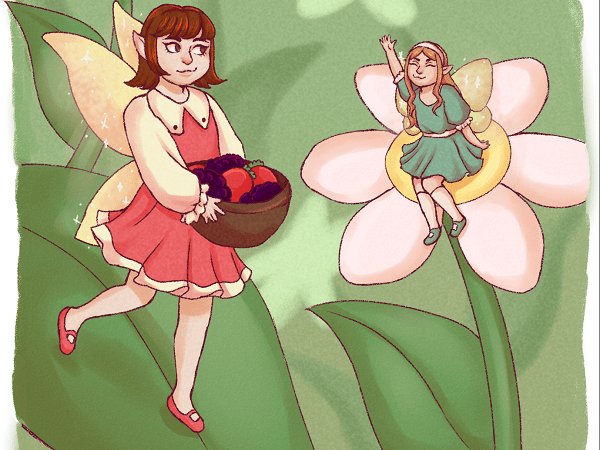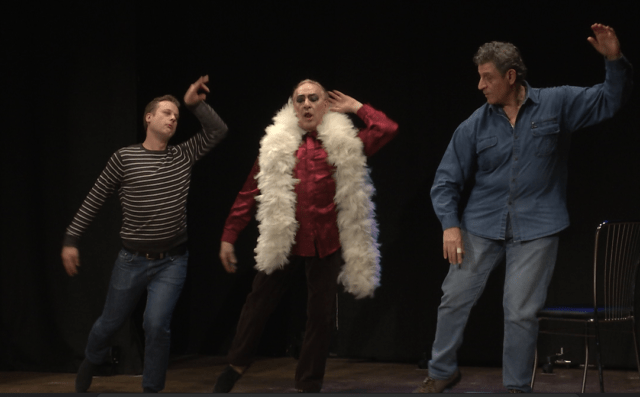Il terzo occhio. Evgen Bavcar: Il fotografo cieco

Alla fine, ai miei occhi eri destinata.
(Pablo Neruda)
Evgen Bavcar è nato nel 1946 sui monti della Slovenia. A dieci anni il ramo di un albero lo colpì sul viso: in seguito a questo incidente perse l’ occhio destro. Dopo un anno un piccolo oggetto metallico trovato per terra risveglio la sua curiosità. Questo oggetto era una mina. La prese tra le mani e mentre giocava con il martelletto la mina esplose, ferendolo all’occhio sinistro. Perse ugualmente la vista dell’unico occhio che aveva, finché non fu in grado di distinguere nemmeno la luce.
Nel 1972 con una borsa di studio a Parigi per studiare filosofia. Laureatosi in filosofia, ottiene un dottorato ottenuto alla Sorbona con una tesi sull’estetica di Adorno e Bloch. Evgen Bavcar parla francese, italiano tedesco, spagnolo, portoghese. Potrebbe sembrare un ossimoro, perché Evgen Bavcar scatta fotografie pur essendo cieco. Vede, ma vede nel buio. Gli occhi – come dice Evgen Bavcar – sono nella mente.
Ci sono gli occhi dell’anima. Ricordate il mito della caverna del settimo libro della Repubblica di Platone? Gli uomini sono come tanti prigionieri incatenati con la faccia rivolta verso il fondo della caverna in cui sono rinchiusi. Alle loro spalle scorrono delle statuette, di cui vedono le ombre proiettare sulla parete che sta loro di fronte. Pensano che quelle ombre siano cose reali, finché non riescono a liberarsi dalle loro catene. Così finalmente vedono e si accorgono che le ombre erano solo le immagini delle statue, e che quelle statue sono a loro volta copie di oggetti reali che stanno fuori dalla caverna. I prigionieri, una volta usciti dalla caverna, siccome sono accecati dalla luce improvvisa a cui non sono abituati, non possono vedere ancora direttamente gli oggetti reali, ma solo le loro figure riflesse nell’acqua.
Omero racconta l’origine della cecità di Demodoco, cantore alla corte di Alcinoo, re dei Feaci, sottolineando la stretta correlazione tra cecità e doti superiori. In Grecia, nel IV sec aC, Aristotele sottolineava lo sviluppo delle capacità mnemoniche consequenzialmente alla cecità, mentre una sentenza dell’oracolo di Delfi aveva già definito la memoria come la “vista del cieco”.
Chi è che vede realmente: noi o Evgen Bavcar?
Sicuramente Evgen Bavcar: vede, ma vede nel buio. Il buio non è sempre nero come noi crediamo, perché nel buio vediamo le immagini dell’anima. Evgen Bavcar di solito ama realizzare i suoi scatti di notte, con l’ausilio di luci portatili che illuminano i soggetti. Con la parola buio si intende la mancanza di luminosità nell’ambiente e l’impossibilità che ne consegue di controllare gli eventi che accadono nello spazio circostante. Però la mancanza della vista non impedisce la costruzione mentale dello spazio. Nel buio vivono le nostre metafore, i nostri riflessi.
Se un cieco decide di fotografare, sicuramente deve affrontare problemi tecnici che sono di sua esclusiva competenza. Alcune volte parte da un’ idea precisa presente nella sua mente e “usa” gli occhi di qualcun’altro affinché gli descriva il procedimento e i risultati ottenuti. Altre volte scatta personalmente fotografie alla folla parigina pur non vedendola, ai passanti anonimi che incrocia, attratto dalle loro voci o dalle loro parole catturate tramite il senso dell’udito. Molti chiedono ad Evgen Bavcar perché ama fotografare, e lui risponde: «Anche chi non può vedere ha dentro quella che potremmo definire una necessità visiva. Una persona al buio in una stanza brama la luce e la cerca ad ogni costo. I ciechi agognano la luce così come un bambino su un treno desidera rivedere la luce del sole mentre attraversa un tunnel.»
Un altro fotografo che è completamente cieco è Pete Eckert «Voglio mostrare al mondo che posso vedere usando i miei altri sensi, i ricordi, le emozioni, i suoni e il tatto», racconta. Solo interagendo con il mondo dei vedenti posso demolire i loro pregiudizi sul nostro universo. Il metodo creativo usato da Eckert è unico: «Impiego la pellicola fotografica come una tela sulla quale fissare ciò che i miei altri sensi portano all’ attenzione dell’ occhio mentale». Il risultato sono dei collage visivi dal sapore surreale, che fondono ricordi lontani ed emozioni tattili-auditive presenti;
La cecità è come uno specchio rotto per cui il mondo comune è un mosaico di frammenti isolati. Il dono profetico e la cecità furono da sempre interpretati come una sorta di compensazione; gli indovini, ad esempio, diventavano a volte ciechi proprio per la loro conoscenza superiore o per aver raccontato agli uomini ciò che sapevano. Un esempio dei più noti è dato dal personaggio di Tiresia, descritto da Omero nell’Iliade come un veggente cieco al quale l’arte profetica era stata concessa a confronto della cecità inflittagli dopo aver visto Atena nuda.
Borges ha accettato la cecità con rassegnazione, anzi come un dono e perfino con ironia. Ha detto: “La cecità non è stata per me patetica perché è stata un processo assai lento” anche “Quando sogno, non sono cieco”.
Apostolos Apostolou. Scrittore e professore di filosofia.
Redazione Radici