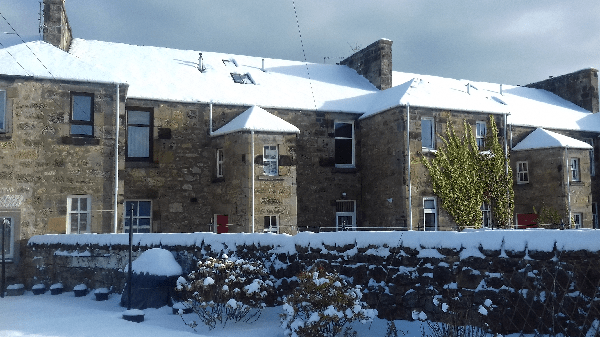Il viaggio verso l’Argentina

di Paola Cecchini
‘I sottoscritti vi avverte il nostro viaggio fatto che è stato cattivo, non per il mare ma per come ci hanno trattato la Società.
A Genova ci hanno trattato peggio dei maiali per mangiare e per dormire a tavolaccio peggio dei reclusi in mezzo a un puzzo che la gente credeva di morire sfeziati per la gran puzza, la maggior parte ha dovuto passeggiare quasi tutta la notte per Genova.Durante il viaggio siamo stati come le sardelle e cinque o sei li abbiamo lasciati in mare. Hanno caricato 1400 passeggeri in un bastimento di 700 o al massimo di 800.
I sottoscritti vi pregano di metterlo questo brutto viaggio sulla Provincia Maceratese’.
Pubblicata ne ‘La Provincia marchigiana’ dell’11 gennaio 1905, questa lettera, scritta da braccianti emigrati a Buenos Aires, la dice lunga sui viaggi oltreoceano.
Non è un caso che i bastimenti che trasportavano emigranti venivano definiti tonnellata umana o navi di Lazzaro: nella stiva delle navi più grandi prendevano posto anche duemila persone, mentre la capacità reale sarebbe stata tra seicento e mille. Non esistevano controlli, tutto era lasciato alla discrezione degli armatori.
Questi ultimi vennero accusati nel 1897 dall’on. Pentano in un discorso alla Camera dei deputati dove lamentò chel e navi utilizzate sono le peggiori per la velocità (circa 30 giorni di viaggio), l’igiene e la tecnica di costruzione, dal momento che spesso vengono adibite al trasporto passeggeri vecchie navi mercantili con ponti posticci.
Nicola Malnate, che ricopriva l’incarico di ispettore del porto di Genova, confermò nel 1898 che il trasporto degli emigranti avveniva sulle stesse imbarcazioni utilizzate per la tratta degli schiavi; la velocità di navigazione non superava le otto miglia l’ora ed ogni passeggero di terza classe disponeva di meno di due metri cubi d’aria contro i due e mezzo prescritti:
L’odore che veniva dalle stive attraverso i boccaporti era tale da non poter immaginare fosse di persone umane…
Per saperne di più, affidiamoci alla testimonianza di un medico di bordo, Teodoro Ansermino, che denunciò al riguardo:
Manca lo spazio, manca l’aria…L’aria soprattutto manca e pare un controsenso trattandosi di un viaggio sull’oceano dove c’è tanta dovizia di spazio e di orizzonte. Eppure per gli emigranti più poveri, lo spazio è limitato e l’orizzonte si rinserra tra le assi delle stive dove stanno pigiati a migliaia.
Entriamo dentro un bastimento. La vita a bordo? Ecco come il medico la descrive:
Sulla maggior parte i marinai ed i fuochisti ci stanno come cani, l’infermeria è un bugigattolo, i luoghi che dovrebbero essere più puliti fanno orrore e per i 1.000 e 500 viaggiatori di terza classe non c’è un bagno! Mancano le camere mortuarie, gli ospedali esistono di nome, la farmacia è incompleta quasi sempre, l’ospedale è una finzione, mancano le cabine di isolamento!
La presenza del medico non costituiva un punto di riferimento per gli emigranti, perché i regolamenti italiani fanno del medico di bordo una specie di personaggio da parata. Né può esserci un buon corpo sanitario nella nostra Marina mercantile senza una scuola preparatoria speciale e senza una carriera, sia pur modestissima, alla quale i medici marittimi avrebbero diritto.
Talché, date queste circostanze, il sanitario di bordo è presto esautorato e si trova impotente a fare il suo dovere.
Credo di poter dichiarare che senza una forte dose di spirito di sacrificio, di abnegazione personale, si vede rassegnarsi ad essere medico di bordo cogli emigrati chi non sa trovare di meglio.
A poco a poco il dovere professionale scompare per far posto all’interesse esclusivo delle Compagnie e del bastimento e il medico diviene in realtà un funzionario che è a bordo del vapore, non nell’interesse dell’emigrante, ma a salvaguardia della Compagnia. E’ una firma necessaria, è un complemento del regolamento; nel qual caso gli emigranti hanno più da sperare nell’umanità e nella coscienza dei comandanti e dei marinai che non nell’autorità del medico.
Oltre al problema dell’igiene, vi era quello dell’alimentazione:
Il cibo degli emigranti spesso è scarso, più volte è cattivo. E di questo non sono sempre responsabili le Compagnie, ma piuttosto il sistema di approvvigionamento e le camorre del personale di bordo. Per essere imparziale, dirò che molto si è fatto e preme a me di rendere giustizia alla Compagnia di Navigazione Generale Italiana la quale, più di tutte le altre, studia di togliere gli abusi a vigilare e provvedere a che ciò che essa spende per i passeggeri di terza vada effettivamente a convertirsi in cibo e bevande per gli emigranti.
Però, una volta il piroscafo in viaggio, il controllo diventa difficile e tutte le Compagnie hanno lo stesso tarlo, quello del personale.
Commissari, sotto-commissari, dispensieri, maggiordomi, cuochi e camerieri, tutti hanno interesse a scappar fuori gl’incerti, speculando sui passeggeri. La cambusa è il sancta sanctorum, chiuso ai profani e la sua storia non è certo esattamente registrata nei conti di bordo.
E parrà impossibile al lettore di terra, mentre lo capirà benissimo il lettore di mare, quanto questa questione si colleghi con quella della moralità.
Come? Il nostro testimone ce lo spiega:
In quella vita di privazioni, di prostrazione morale, fra dolori che si lasciano e dolori che si incontreranno, lo spirito delle donne si abbatte, la volontà domina meno. Si aggiunga il pigiamento, il contatto continuo, l’eccitabilità che reca il mare sull’organismo e sui nervi.
Ora è massima stabilita che la donna di terza classe, se vuole ottenere qualche favore dal personale di bordo, un cibo meno cattivo, una cuccetta più comoda, debba mostrarsi docile e non fare la ritrosa.…E giacché sono su questo argomento, aggiungerò che non solo la loro virtù è insidiata con i piccoli favori, i privilegi e le ghiottonerie che alle preferite concedono i don Giovanni del personale di bordo, ma talvolta colla persecuzione, con le minacce ai padri e ai fratelli, con la terrorizzante prospettiva dei ferri che raramente si applicano ma che in quel mondo di teste grulle è il babau di tutta la traversata.
E lì, in quelle tre settimane o quattro di viaggio, si svolgono fatti intimi drammaticissimi, coi don Rodrighi e talvolta anche i bravi e magari…la peste di Milano.
La caccia alle ragazze italiane non interessava soltanto il personale di bordo, ma continuava allo sbarco ad opera degli impiegati delle Casas de Inmigración, degli agenti americani incaricati di ricevere gli immigranti, dei sensali di collocamento, dei rappresentanti delle colonizzazioni, tanto che è ben difficile che non debbano soccombere alle esigenze e talvolta alle birbonate, ai ricatti, con cui sono assediate arrivando in America dalle persone nelle cui mani sta incondizionatamente l’arbitro dell’avvenire per la ragazza e la sua famiglia.
Vi era poi qualcosa di più turpe ed osceno, ossia il reclutamento che si cerca di fare fra di esse per le case di piacere di Buenos Ayres o di Montevideo. In un paese come il Plata dove approdano centomila scapoli all’anno, è facile comprendere quanta necessità ci sia di provvedere un forte esercito di sacerdotesse di Venere Pandemia.
E perciò gli arrivi delle povere italiane sono spiati e sfruttati a tal fine. Anzi, si va più in là. Alcune di queste case tengono mezzani a Las Palmas o San Vincenzo che si imbarcano a bordo dei piroscafi di emigranti e, mescolandosi fra le donne, vanno facendo promesse e seminando lusinghe per trovar femmine prima anche che siano sbarcate.
Questi mascalzoni, bisogna dirlo a nostra vergogna, sono quasi sempre italiani e delle province meridionali…
Un bastimento di emigranti rappresentava uno degli spettacoli più tristi al mondo, ricordava Adriano Colocci, già direttore del Corriere Adriatico:
Tutta quella miseria, quei cenci, quel lezzume fan male a chi ha senso di umanità. Quante vergogne, quanti errori, quante colpe nostre rappresenta quella nave di raminghi! La tirannia di un signorello, la durezza del fittavolo, l’avidità dell’usuraio, la cecità del nostro sistema fiscale e sociale, tutto ciò ed altro ancora va ricercato nella biografia di quella povertà errante.
E cosa strana! In quel brulichio di gente, fra quel vocìo dei nostri cento dialetti, in quegli scoppi di vivacità italiana, mai una parola che denoti rimpianto della patria lasciata. Rammento che, sbarcando in America da una nave di emigranti, ci venne incontro un vaporino sul quale un’orchestrina suonava, con evidente gentile offerta a noi, l’Inno di Garibaldi.
Ebbene! Di quei mille e settecento italiani non uno applaudì. Affacciati sul piroscafo, sembravano infastiditi di questo ricordo della patria che anche lì, in quel momento di metempsicosi, li inseguiva con una persistenza incresciosa. E tutti scesero, sciogliendo per la prima volta la voce ad un grido inusitato: “Viva l’America!”
O come vorrei che i nostri ministri, deputati e politicanti di ogni risma, vedessero certi spettacoli!
La traversata veniva chiamata nelle Marche lu passàgghju, termine che suona sinistro per via che designa nel parlare allusivo, anche il trapasso dell’uomo da questo mondo.
E lu passàgghju faceva paura, non solo per questo lugubre richiamo e per la lunga durata, ma altresì per il costo altissimo e soprattutto per i travagli dell’esistenza a bordo, tanto più sofferti in quanto si trattava di gente che aveva vissuto sempre in campagna, a cui il mare risultava tanto misterioso quanto ostico.
Prima della partenza, si affidavano all’aiuto divino: alla Madonna di Loreto o a S. Marone di Civitanova che, secondo quanto si diceva, proteggeva dagli annegamenti.
Chiudiamo gli occhi ed immaginiamoli in quei momenti: si imbarcavano a Genova, dopo un intero giorno di treno. Avevano tra le mani lu spapiè rrùsciu, il passaporto con copertina rossa, valido tre anni, secondo le disposizioni dell’epoca.
Come erano vestiti? Indossavano quelli che erano chiamati li pagni de lu passàgghju, gli indumenti della traversata, i più vecchi che avevano nel guardaroba e che, poco prima dello sbarco, venivano gettati nelle acque del porto e sostituiti con li pagni vòni (gli indumenti nuovi); in tale circostanza si tagliavano capelli, i baffi, la barba e le unghie, che per superstizione avevano lasciato crescere durante il viaggio.
Li pagni de lu passàgghju sono entrati nel linguaggio corrente maceratese, al punto che ancor oggi è possibile udire espressioni simili:
Quéssa camìscia me pare quella de lu passàgghju: che ’spétti a ccammiàttela? (Questa camicia mi pare quella della traversata: che aspetti a cambiartela?)
oppure:
Quissu vistitu èsso no’ mme mittirìo mango pe’ lu passagghju!
(Questo vestito non lo metterei neppure per la traversata!) Per le nausee, facevano ricorso ad un rimedio empirico antichissimo: quello di mangiare olive nere conservate sotto sale non appena si fossero avvertiti i primi sintomi.
D’altronde lu mare ‘mbara a ppregà, recitava un adagio popolare della mia regione. Al riguardo Claudio Principi, storico di Corridonia, trascrive in un gustosissimo saggio, il racconto che gli fece un rimpatriato sul suo passagghju avvenuto nel 1899:
“Tra gli emigrati c’era un prete che esortava alla preghiera e predicava il Vangelo. Un giorno narrò l’episodio secondo Giovanni nel quale Gesù si mise a camminare tranquillamente sopra le acque agitate del lago e quando gli apostoli sbalorditi lo presero a bordo della barca dove stavano, questa toccò terra, là dove erano diretti.
Alla fine del racconto, qualcuno chiese al prete:
Perché quissu miràculu ssuscì bbéllu cristu no’ lu fa anghi per noatri, se tutti lu stimo a ppregà notte e gghjòrnu con tutta la divoziò che cce chjidi?(Perché questo miracolo così bello Cristo non lo fa anche per noialtri che lo stiamo a pregare giorno e notte con tutta la devozione che ci chiedi?)
Il prete rispose un po’ scandalizzato:
Perché noialtri non siamo gli apostoli!
Ma in quistu moméndu in pìrìculi ci statimo noatri, mica ll’Apòstuli!(Ma in questo momento in pericolo ci siamo noialtri, mica gli apostoli!) – osservò l’emigrante che dopo un momento sovrappensiero proseguì:
Allòri facce prega’ a la Madonna o a quarche sandu che cce pòle sindì, perché, per me, mica staco a vvardà chji me sarva!” (Allora facci pregare la Madonna o qualche altro santo che ci può ascoltare, perché a me non importa che mi salva!)
Durante le traversate, gli incidenti non mancavano, tanto che i piroscafi (o vapori come erano chiamati nelle Marche) furono definiti vascelli della morte: nel novembre del 1880 l’Ortigia cozzò con il mercantile Long Joseph davanti alle coste argentine del Plata (duecentoquarantanove morti); nel gennaio del 1888 il Sudamerica si inabissò nelle stesse acque (ottanta morti); nel luglio del 1898 La Bourgogne, partita da Le Havre, affondò al largo della Nuova Scozia (cinquecentoquarantanove morti, tra cui molti italiani che sceglievano la città francese se clandestini); nell’ottobre 1927 fu la volta della Principessa Mafalda, nave ammiraglia della nostra Marina commerciale, che naufragò davanti alle coste brasiliane, anche se i motori si erano già fermati otto volte nel Mediterraneo (trecentottantacinque morti).
Il naufragio più famoso in assoluto fu quello del Sirio, piroscafo della Navigazione Generale Italiana, avvenuto il 4 agosto 1906 al largo di Cabo Palos, nella costa orientale della Spagna, a venticinque chilometri da Cartagena. I danni furono gravissimi, ma l’affondamento totale avvenne soltanto sedici giorni dopo:
Avrebbero potuto salvarsi quasi tutti, ma l’evacuazione fu così caotica e disperata che alla fine il bilancio, stilato dai Loyd’s, fu apocalittico: 292 morti, anche se in realtà pare che le vittime siano state ancor di più: tra le 440 e le 500.